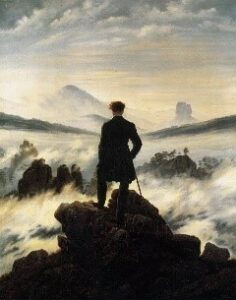

Dal principio alla fine dell’evo antico poco o nulla muta nel modo di giudicare l’artista in confronto al poeta. A quest’ultimo di quando in quando si tributano speciali oneri: è ritenuto un veggente, un profeta, un dispensatore di gloria e un’interprete di miti; l’artista, invece, è e rimane il “vile meccanico”, il banausos, cui nulla è dovuto oltre il salario.
A creare questa differenza concorrono diverse cause: anzitutto l’artista viene pagato e non ne fa mistero, mentre il poeta, anche al tempo della sua peggior soggezione, è considerato ospite e amico del suo protettore; inoltre, il lavoro del pittore e dello scultore sporca le mani, e sporchi sono i materiali e gli arnesi c’essi debbano usare, mentre il poeta ha le vesti e le mani pulite, e questo, per un’epoca non ancor dominata dalla tecnica, ha maggior peso di quanto si possa immaginare ma, soprattutto, l’artista deve fare un lavoro manuale e sottoporsi a un compito faticoso, a uno sforzo fisico, mentre la fatica del poeta non dà nell’occhio a nessuno.
La scarsa considerazione verso chi deve lavorare per vivere, il disprezzo di ogni attività remunerata e in generale di ogni lavoro produttivo, nasce dal fatto che ogni attività di questo genere, in contrasto con le occupazioni signorili del governo, della guerra e della palestra, sa di sottomissione, servizio e obbedienza. Nell’epoca in cui agricoltura e allevamento, oramai pienamente sviluppati, son affidati alla donna, la guerra diventa l’occupazione principale dell’uomo, e la caccia il suo principale svago.
Entrambe richiedono forza ed esercizio, ardire e destrezza, e sono onorevolissime, mentre ogni lavoro minuto, paziente, estenuante passa per un segno di debolezza, ed è quindi spregevole, ogni attività produttiva, ogni occupazione che serva per vivere, è considerata avvilente. Tocca agli schiavi, perché è disprezzata; ma non è (come si può ritenere) disprezzata perché tocca agli schiavi.
L’associazione del lavoro fisico col lavoro servile contribuisce tutt’al più al consolidamento del primitivo concetto di prestigio, ma questo è evidentemente anteriore all’istituto della schiavitù.
L’antichità classica perviene a risolvere l’intima contraddizione fra il disprezzo del lavoro manuale e l’alta valutazione dell’arte come strumento di culto e di propaganda, separando l’opera dalla persona dell’artista, cioè onorandola pur disprezzandone l’autore.
Se confrontiamo con questa concezione quella moderna, che innalza l’artista sull’opera, quando non possa mantenere la finzione dell’artista perfettamente riflesso dall’opera, noi vediamo quanto diverga la valutazione odierna del lavoro da quella dell’antichità. La differenza è enorme, benché gli uomini, non si siano liberati neanche oggi dal concetto primitivo dell’ozio onorevole. Ma certo più profondamente del nostro tempo ne era compresa l’antichità.
Finché dura in Grecia il predominio dell’aristocrazia guerriera, dura intatto il concetto dell’onore primitivo, parassita e brigantesco, e, alla fine di quel predominio, è sostituito da un concetto analogo; quello della vittoria nell’agone.
Come sola occupazione nobile e degna vale, quando si posano le armi, la gara sportiva. Così il nuovo ideale si ricollega all’idea di una lotta che occupa tutta la vita ed esige che i suoi fedeli vivano di rendita.
Per il ceto dominante in Grecia e per i suoi filosofi la “pienezza dell’ozio” è la premessa do ogni cosa bella e buona, è il sol bene che renda la vita degna di esser vissuta. Soltanto l’ozioso può consentire la saggezza, la liberta interiore, dominare e godere la vita.
E’evidente la dipendenza di questo ideale dalla condotta di vita del ceto abbiente. Nel concetto del kalokagathìa, della perfetta educazione fisica e sprirituale, nel disprezzo di ogni cultura unilaterale e di ogni ristretta specializzazione, di esprime chiaramente l’ideale di una vita fuori di ogni vincolo di professione.
Ma quando Platone, in alcune Leggi, sottolinea il contrasto fra la paideia che arricchisce tutto l’uomo e l’abilità professionali, egli dà evidentemente espressione, oltre che all’antica idea aristocratica della kalokagathìa, anche alla propria ostilità alla nuova borghesia democratica che si nasconde dietro la differenziazione professionale. Agli occhi di Platone ogni specialità, ogni occupazione nettamente circoscritta è banausia, è un tratto caratteristico della società democratica.
La vittoria del costume borghese sul costume aristocratico, nel corso del IV secolo e dell’età ellenistica, comporta la parziale trasformazione dell’antica idea di prestigio; ma nemmeno ora si rispetta il lavoro per se stesso o gli si attribuisce un valore educativo nel senso della nostra etica borghese; lo si scusa, indulgendo a chi sa far denari.
Lo storico Burckhardt, già in Grecia, osserva non solo l’aristocrazia, ma anche che la borghesia disprezza il lavoro, in contrasto con la borghesia medievale che fin dall’inizio lo tiene in grande stima, e anziché adottare il concetto di onore della nobiltà, impone ad essa il proprio concetto di onore professionale.
Decisive per il valore che un popolo annette al lavoro sono, per il Burckhardt, le circostanze in cui si sono foggiati i suoi ideali di vita.
Quello dell’Occidente odierno derivano dalla borghesia medievale, che supera via via la nobiltà in beni materiali e spirituali. Quelli dei Greci invece derivano dall’età eroica, da un mondo ignaro del principio di utilità, e costituiscono un patrimonio a cui si attennero ancora secoli.
Solo quando gli ideali agonistici cessano di operare, a un momento cioè che coincide con la fine della polis, si annuncia una valutazione affatto nuova del lavoro e quindi dell’arte figurativa; ma l’antichità non era destinata a compiere il passo decisivo nel senso di questa trasformazione.
Nell’Atene classica la posizione economica e sociale di scultori e pittori è pressoché la stessa che nei tempi eroici e omerici, nonostante la straordinaria importanza acquistata dalle opere d’arte per la polis vittoriosa e per l’orgogliosa esibizione della sua potenza.
Si continua a considerare l’arte come pura abilità manuale, e l’artista come un comune operaio, che non ha nulla che fare coi valori spirituali più elevati, con la scienza e con la cultura.
Egli è pur sempre mal pagato, senza sede fissa, e mena la vita instabile dei vagabondi, per lo più straniero senza diritti nella città che gli dà lavoro.
Bernhard Schweitzer spiega la posizione immutata dell’artista con le condizioni economiche, sempre ugualmente sfavorevole in cui egli lavora per tutta l’epoca della libertà greca.
In Grecia lo stato cittadino è, e rimane, il solo grande committente di opere d’arte; non ha quasi concorrenti, poiché non c’è privato che, per i costi relativamente alti dei prodotti artistici, gli si possa opporre o affiancare. Fra gli artisti, invece, cioè una accanita concorrenza, che non è minimamente compensata dalla gara fra le città. Un mercato libero (che potrebbe valorizzarli) non sussiste né all’interno delle singole città, né nella loro competizione reciproca.
Il mutamento nella condizione dell’artista, che si osserva al tempo di Alessandro il Grande, è in stretto rapporto con la propaganda messa in opera per il conquistatore. Il culto dell’individuo, che si sviluppa dal nuovo culto degli eroi, torna a favore dell’artista, che dispensa la gloria e la riceve.
Le esigenze delle corti di Diadochi e la ricchezza che si accumula nelle mani dei privati aumentano la richiesta, e quindi il pregio dell’arte e la considerazione in cui è tenuto l’artista. La cultura filosofica e letteraria penetra anche nella cerchia degli artisti; essi cominciano a emanciparsi dall’artigiano e a formare un ceto a sé di fronte ai lavoratori manuali.
I ricordi e gli aneddoti tratti dalla vita degli artisti mostrano benissimo il grande mutamento dell’epoca classica. Il pittore Parrasio, firmando le sue opere, dà prova di un’arroganza inconcepibile ancora poco tempo prima. Zeusi, si acquista, con la propria arte, una ricchezza quale nessun artista aveva mai posseduto. Apelle non è soltanto il pittore di corte, ma anche l’amico di Alessandro il Grande.
Cominciano a correre aneddoti sull’eccentricità di pittori scultori, e infine possiamo osservare fenomeni che ricordano l’omaggio tributato all’artista nei tempi moderni.
A tutto ciò si aggiunge, anzi vi è sottointeso quella che Schweitzer chiama “la scoperta del genio artistico” e che risale alla filosofia di Plotino.
Questi scorge nel bello un tratto essenziale del divino; secondo la sua metafisica, la realtà spezzata e frammentaria riacquista solo attraverso la bellezza e nelle forme dell’arte quella totalità che ha perduto allontanandosi da Dio.
Grande è il prestigio che doveva venire all’artista dalla diffusione di una simile dottrina. Il magico alone del veggente ispirato dal dio torna ad avvolgerlo come nella preistoria.
Egli appare di nuovo l’invasato, l’essere carismatico iniziato ai misteri com’era stato ai tempi della magia.
Fin dal primo secolo Dione Crisostomo paragona l’artista al Demiurgo; il neoplatonismo sviluppa questo parallelo e sottolinea il momento creativo nell’opera dell’artista.
Si spiega così l’atteggiamento contrastante verso l’artista proprio di epoche più tarde, soprattutto dell’impero romano e della tarda antichità. Roma repubblicana e l’impero agli inizi valutavano ancora il lavoro manuale e la professione dell’artista come la Grecia eroica e quella oligarchica e democratica.
Ma a Roma, dove i più antichi ricordi risalivano a una popolazione agricola, il disprezzo del lavoro non discendeva direttamente dall’originaria casta guerriera: doveva passare per un’età in cui anche i ricchi e gli uomini politici avevano lavorato nei campi, per riallacciarsi a idee la cui continuità storica era da grande tempo interrotta.
Comunque, il bellicoso popolo di contadini, che domina Roma nei secoli III e II è, nonostante la sua famigliarità col lavoro, tutt’altro che ben disposto verso l’arte e gli artisti.
Solo con la trasformazione della civiltà attraverso l’economia monetaria e urbana, e con l’influsso greco, comincia a mutare l’importanza sociale del poeta, e poi, a poco a poco, anche quella dell’artista.
Ma solo nell’età augustea il mutamento diviene più sensibile e si manifesta da un lato nella figura del “vate”, dall’altro nell’ampiezza e nella forma assunta dal mecenatismo privato accanto a quello della corte.
Tuttavia l’arte continua a essere apprezzata meno della poesia. Durante l’impero, i pittori dilettanti diventano sempre più numerosi fra i patrizi, e la moda trova seguaci persino tra gli imperatori; Nerone, Adriano, Marco Aurelio, Alessandro Severo, Valentianiano I, tutti dipingono.
Ma la scultura, forse perché più faticosa, e per le più complesse esigenze tecniche, continua a essere considerata un’attività volgare. E anche la pittura è considerata un’occupazione rispettabile solo quando non viene esercitata per denaro.
Pittori oramai celebri non si fanno più pagare i loro lavori, e Plutarco, per esempio, distingue Polignoto dal volgo solo perché ha affrescato un edificio pubblico senza esigere alcun compenso.
Seneca mantiene ancora l’antica distinzione tra l’opera d’arte e l’artista, “si prega e si sacrifica davanti alle immagini degli dei” egli dice, “ma si disprezza lo scultore che le ha fatte”.
Ed è nota l’affermazione analoga di Plutarco: “Nessun giovane d’alto sentire, davanti allo Zeus di Olimpia o all’Hera di Argo, vorrebbe diventare un Fidia o un Policleto”, è un linguaggio abbastanza chiaro contro gli artisti; ma poi si dice che il nostro giovane non vorrebbe essere neppure Anacreonte, o Filemone, o Archiloco; poiché, se anche, dice Plutarco, godiamo delle opere, i loro creatori non meritano di essere emulati.
L’equiparazione del poeta con lo scultore, è un tratto assolutamente estraneo alla classicità, e nostra l’incoerenza del tardo Impero di fronte a tutti questi problemi.
Il poeta condivide la sorte dello scultore, perché anch’egli è soltanto uno specialista e segue le regole precise di una dottrina, che traduce l’ispirazione divina in una tecnica razionale.
Il riconoscimento della personalità artistica, è evidentemente in rapporto con l’estetismo imperiale, e indirettamente forse anche col neoplatonismo e con dottrine filosofiche affini; ma la simultanea condanna dall’artista, una voce che non si spegne mai accanto all’altra, prova che l’antichità, anche nell’epoca più tarda, rimane legata alla concessione preistorica che fa consistere il prestigio nell’”ozio ostentativo” (Veblen), e, nonostante la sua cultura estetica, è semplicemente incapace di concepire un’idea come quella del “genio”, propria del Rinascimento e dell’età moderna.
Poiché solo con questo concetto diventa indifferente in quale forma e con quali mezzi si esprima la personalità, purché riesca a esprimersi, o anche solo ad accennare ciò che non riesce a esprimere.
Monica Isabella Bonaventura – Maestra d’Arte

Be the first to comment on "POETI E ARTISTI NELL’ANTICHITA’"